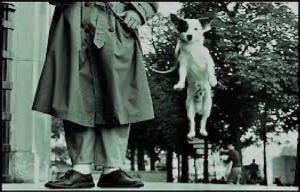

"La memoria sensoriale delle relazioni: Commemorazione di Andrea Seganti” (6 febbraio 2025). Report di Donatella Verrienti
- Dettagli
- Categoria: Report eventi scientifici
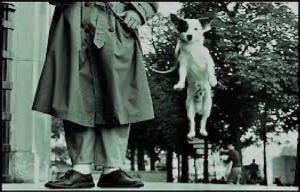
La serata scientifica del 6 febbraio 2025, pensata dal Centro di Psicoanalisi Romano per ricordare ad un anno dalla scomparsa Andrea Seganti, Membro Ordinario con Funzioni di Training, si apre con l’intervento di Diana Norsa, attuale Presidente del Centro stesso, che individua tre temi chiave attorno a cui il pensiero dell’autore si è sviluppato: psicoanalisi di gruppo, intersoggettività e validazione dell’operato clinico. Nel ricordo affettuoso che di lui la Norsa propone, Seganti ci appare come una figura dal carattere a tratti critico e scontroso, in ragione anche di importanti patologie da cui era afflitto, ma sempre attraversato da una genuina passione per la clinica psicoanalitica – con particolare attenzione per le aree psicotiche della mente – che sapeva coniugare con un altrettanto vivo interesse per la ricerca. Due ambiti, dunque, quello della clinica e quello della ricerca in Psicoanalisi che si proponeva di integrare in una spinta etica volta alla legittimazione e validazione scientifica dei complessi movimenti trasformativi osservabili all’interno del processo analitico.
Con l’ausilio di aneddoti narrati da Claudio Neri, ne rievoca il percorso formativo e professionale menzionando gli anni del Pollaiolo, anni in cui, in qualità di giovane medico specializzando in Psichiatria, A. Seganti condivise l’esperienza di formazione nell’Analisi di Gruppo con colleghi altrettanto appassionati (Corrao, Barnà, De Toffoli, Neri, Bonfiglio, Palmieri, Riolo, Correale, Sarno, Petrini, ecc.), impegnato con loro nella costruzione di un “laboratorio” che si proponeva, come specifico vertice di osservazione, la declinazione del pensiero psicoanalitico all’interno dell’analisi di gruppo. Fu quell’esperienza l’espressione di un grande fermento ideativo e culturale sviluppatosi a Roma lungo un ventennio e culminato nelle Conferenze Italiane di W. Bion. A quegli anni fece seguito un nuovo periodo in cui il suo sguardo si spostò sulla ricerca filosofica divenendo membro di un gruppo di studio formatosi intorno a Stefano Garrone, ricercatore presso la cattedra di Filosofia teoretica dell’Università La Sapienza di Roma. Proprio all’interno di questo ambiente culturale così fecondo che si andò confermando in lui il desiderio di mettere in primo piano il vertice scientifico come lente di approfondimento del movimento psicoanalitico, un’urgenza contrapposta a quella di Bion che viceversa, matematico d’origine, aveva avvertito la necessità di spingersi più verso una dimensione ermeneutica come metodo di validazione del processo. Questo piano prospettico lo rese più permeabile fruitore delle scoperte dell’Infant Research, dei modelli di attaccamento, interesse poi consolidatosi nella proficua collaborazione con il gruppo di ricerca di P. Fonagy a Londra - di cui recano traccia alcune sue pubblicazioni sull’International Journal of Psychoanalysis - ed infine della Teoria dei Codici Multipli di Wilma Bucci, divenendo il curatore di un’importante intervista che ne introdusse in Italia la diffusione.
Accennando ai sui due principali scritti, Diana Norsa cita le parole di Nino Dazzi che nella prefazione del “La memoria sensoriale delle relazioni” (1995) ricorda l’incontro avvenuto nel 1989 con Merton Gill e la fascinazione esercitata su di loro dalla proposta di Gill relativa alla costruzione di un metodo che empiricamente consentisse la validazione del processo analitico in una prospettiva intersoggettivistica che ampliava il senso tradizionale del concetto di transfert, aspetto divenuto centrale nel suo lavoro di ricerca e che ne ha permeato il carattere profondamente innovativo, più vicino alla scuola statunitense e a quella tedesca di Kakele ma distante dai più consolidati scenari della teoria psicoanalitica. Del secondo scritto “Teoria delle mine vaganti” (2009) ricorda l’accento rivolto dall’autore alle primitive esperienze di sviluppo in cui la possibile dissonanza presente tra le proprie esperienze sensoriali e il carattere dei “messaggi linguisticamente espliciti” apre la possibilità di sentire la relazione come ingannevole e fonte di tradimento, dimensione traumatica in grado di dare forma e condizionare la successiva vita relazionale. Suggestiva è inoltre la sua menzione ad un piccolo pamphlet non pubblicato dal titolo “Il manuale di psicologia traffichina: come sopravvivere alla guida del vostro motorino e guarire dalla vostra incipiente impotenza”, in cui in modo sarcastico si delinea la distanza del protagonista da una modalità che prevede traffici ambigui e soluzioni ingannevoli, forme che mortificano ed avviliscono l’essere, aspetti verso cui Seganti nutriva una certa avversità ed insofferenza.
La serata prosegue con il ricco e puntuale contributo di Teodosio Giacolini, Membro Ordinario della SPI, che ricorda come Seganti, insieme a S. Bordi, abbia rappresentato una figura significativa nel suo percorso di formazione per l’apertura che entrambi proponevano all’interno della Psicoanalisi Italiana ai due emergenti filoni di ricerca, l’Infant Research e la Ricerca sulle Psicoterapie, congiuntamente all’attenzione per l’opera di J. Bowlby che negli anni ’90 iniziava una sua progressiva diffusione. L’influsso di queste aree confluì nell’opera più compiuta del “La memoria sensoriale delle relazioni”, nata nell’intento di dare risposta all’interrogativo su quali fattori designassero l’efficacia della psicoterapia attraverso la formulazione rigorosa di una teoria passibile di verifica e comparazione con altri modelli psicoterapeutici. Ciò costituiva un modo per emanciparsi dall’idea di una teoria unica ed onnicomprensiva della mente, marcando una forte distanza dall’approccio intrapsichico Freudiano, per rivolgersi alle più recenti teorie evolutive dello sviluppo psichico in cui il focus era rivolto alla dimensione interattiva della costruzione della mente, al rilievo dato al “bambino osservato” più che al “bambino” clinico nella distinzione introdotta da D. Stern che attribuiva al neonato precise competenze emotive e cognitive ed una predisposizione alla relazione ed alla regolazione degli stati emotivi interni. In questa area di ricerca particolare interesse destò in lui – come si deduce dallo scritto - il concetto introdotto da Broucek (1980) relativo al sentimento di efficacia visto come espressione del senso di gioia e di appagamento che nasce dalla corrispondenza tra l’attesa del neonato a seguito della sua azione e la risposta dell’ambiente stesso. La disattesa di questa congiunzione armonica sarebbe viceversa all’origine di un comportamento di ritiro dall’interazione e di ripiegamento su di sé funzionale al ripristino di uno stato di coerenza interna che svincola il soggetto dalla risposta ambientale. E’ in questo aspetto – continua Seganti nel suo scritto – che risiederebbe l’origine del costituirsi di strategie intra e interpsichiche modulatrici della relazione con l’oggetto che assicurano la vicinanza adattativa con il caregiver ma al contempo ne sanciscono la discontinuità come funzione protettiva della coerenza del Sé. Dalla costellazione disarmonica tra bisogno del neonato e reazione delle figure di accudimento deriverebbe dunque una strategia di adattamento che presuppone la scissione di reazioni di frustrazione e protesta, nella sopravvivenza viceversa delle sole emozioni positive che risultano più in linea con le richieste esterne. E’ questo incastro collusivo a porsi come condizione che da forma alla sofferenza psichica che, esplicitandosi sia sul versante dell’intrapsichico che su quello relazionale, impregna il rapporto con l’oggetto nel paradosso di un legame disfunzionale ed alienante ma al, tempo stesso, coercitivamente vincolante.
Nel “La teoria delle mine vaganti” (2009) – prosegue Giacolini - questa tematica sarà ulteriormente approfondita portando a considerare l’esistenza di “mine” presenti nello spazio psichico del soggetto come tracce sensoriali primitive, legate al fallimento delle prime sequenze interattive nel disatteso allineamento tra l’aspettativa del bambino e la risposta dell’ambiente, depositate all’interno della memoria procedurale. Tale concettualizzazione lo pone in una posizione di vicinanza con i costrutti introdotti negli anni ’90 riguardanti la distinzione tra la memoria episodica e quella procedurale, soprattutto nell’idea che la memoria sensoriale di esperienze negative si depositi a formare, nella memoria implicita, una parte significativa del vero Sé del soggetto che permane e che necessita di essere mantenuta occultata al fine di prevenirne un ulteriore diniego. Da qui la possibilità che questi contenuti dell’inconscio non rimosso premano, esprimendosi anche con un impatto “esplosivo” attraverso forme psicopatologiche, per poter riemergere ed ottenere finalmente accesso ad una possibilità rappresentativa ed elaborativa. All’interno di tale approccio concettuale si individua inoltre lo sforzo di definire un metodo, denominato “dei prototipi e delle variazioni”, che indaghi i modelli interattivi depositati nella memoria procedurale del paziente attraverso il loro riproporsi transferalmente nella dinamica psicoterapeutica al fine di studiarne la presenza mediante l’analisi di sedute registrate. Questa prospettiva teorica lo pone dunque in linea con i molti gruppi di ricerca che in quegli anni guardavano ai “depositi procedurali” della mente come un’area di azione e trasformazione terapeutica. Teodosio Giacolini conclude il suo accurato ricordo del pensiero di Seganti soffermandosi sulla sua distanza rispetto alla posizione istintuale di matrice Freudiana che considerava anacronistica e divergente dai più recenti filoni della Psicoanalisi, distanze teoriche su cui lo stesso Giacolini avrebbe avuto il piacere di confrontarsi in un dibattito appassionato.
A seguire l’intervento di Amedeo Falci, Membro Ordinario con funzioni di Training, che si pone l’interrogativo di cosa sia rimasto del fermento culturale ed ideativo che attraversò gli anni 70-90 all’interno di quel gruppo composto da giovani e promettenti psicoanalisti, gruppo di cui faceva parte lo stesso Seganti, che riuniti intorno alla figura di Corrao al Pollaiolo era animato da uno spirito sovversivo, anima rivoluzionaria che l’approccio psicoanalitico incarnava ponendosi in qualità di proposta innovativa dissonante dai tradizionali modi di intendere i sistemi familiari e le categorie psicopatologiche. Per Falci, in questo ambiente culturale di matrice già di per sé “rivoluzionaria”, Seganti fu portavoce di una componente ancor più contestativa in quanto distante dalla matrice pulsionale Freudiana e più prossimo alle teorie psicoanalitiche emergenti nel panorama internazionale (Bowlby, Stern, ecc), aspetto di difformità che finì, tuttavia, per generare critiche aspre e perturbanti verso di lui, espressione di una modalità spesso presente nelle istituzioni – commenta Falci - che si frappone al cambiamento scientifico e rimane fedelmente ancorata ai propri costrutti fondativi in una posizione di “stagnazione” culturale. Prendendo spunto dal ricordo di Seganti di cui rimarca la qualità innovativa di un pensiero aperto alla teoria delle emozioni, alla studio sugli esiti della psicoterapia, alla contaminazione con approcci disciplinari diversi i (matematica, filosofia, neuroscienze), Falci pone l’interrogativo su quanto il carattere eversivo distintivo della Psicoanalisi sia tuttora presente o risulti viceversa sommerso da un atteggiamento normativo poco incline a cogliere e seguire le trasformazioni culturali, cristallizzato in approcci dogmatici che tendono ad ignorano aree scientifiche emergenti e potenzialmente innovative.
Un contributo corale viene infine proposto dalla sala attraverso colleghi ed amici che nel susseguirsi dei loro interventi ne offrono un ricordo caldo ed affettuoso, ad iniziare da A.C. Barnà che ne tratteggia, lungo i molti anni di condivisione del training e della loro protratta amicizia, la sua particolare capacità di accoglienza ed ospitalità. Ne ricorda anche i lati spigolosi del carattere e l’’insofferenza nutrita verso ogni forma di incoerenza ed ipocrisia presente anche all’interno dei sistemi istituzionali verso cui si mostrava coraggiosamente non conforme. Anche nelle parole di L. Solano, B. Bonfiglio e C. Neri ritroviamo l’enfasi posta alle dimensioni di originalità ed anticonformismo che ne hanno contraddistinto il pensiero, a tratti dissonante dalla tradizione psicoanalitica, ma che - come conclude in una comunicazione scritta C. Verde, psicoanalista con cui A. Seganti condivise i suoi ultimi sforzi di ricerca- meriterebbe di ottenere maggiore risalto, potendo divenire per gli allievi oggetto di studio e di approfondimento.
Bibliografia
Seganti A. (1995) La memoria sensoriale delle relazioni, Boringhieri
Seganti A. (2000) Wilma Bucci: intervista sull’inconscio, Rivista di Psicoanalisi 46:5-17
Seganti A. (2009) Teoria delle Mine Vaganti, Armando editore
